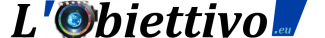Dal ritiro da Kabul all’Aukas, il nuovo corso USA rimescola gli equilibri geopolitici
La fine della presenza in Afghanistan e l’alleanza con Londra e Canberra ridisegnano il futuro dei rapporti internazionali e il G20 di fine ottobre a Roma diventa già un punto di svolta.
A nove mesi dall’inizio del suo mandato, Joe Biden inizia a svelare il tratto che vuole dare alla sua presidenza: sia chi sperava che dopo la “tempesta”-Trump saremmo andati incontro a tempi più tranquilli, sia chi temeva che i suoi quattro anni di mandato sarebbero stati poco incisivi sulla storia mondiale, a quanto pare, si dovrà ricredere.
Nel giro di poche settimane, infatti, la rinuncia al controllo strategico dell’Afghanistan con il fin troppo precipitoso ritiro delle truppe da Kabul e il sorprendente annuncio-bomba dell’Aukus, la nuova alleanza con Australia e Gran Bretagna nell’area Indo-Pacifica che ha spiazzato la Francia e l’Europa, con l’annullamento da parte di Canberra della commessa da oltre 50 miliardi di Euro ai cantieri francesi per la fornitura di sottomarini convenzionali in favore dello sviluppo di quelli nucleari previsti nel triplice accordo di qualche giorno fa, hanno dato la spallata definitiva a due “certezze”, da tempo in crisi, su cui ancora si crogiolava parte del dibattito politico dell’occidente: ossia gli USA “difensori del mondo libero” e il “Patto Atlantico” come faro dei rapporti globali. Ma soprattutto hanno indicato la strada che Biden vuole percorrere per dimostrare ai suoi elettori di avere a cuore gli interessi del popolo e della nazione americana.
Facciamo un passo indietro. La promessa elettorale di ritirarsi dalle zone di conflitto internazionale dove la politica estera USA risultava impantanata, per concentrarsi sulla politica interna e sulle minacce internazionali più urgenti è un qualcosa che gli elettori americani ascoltano ormai da almeno un decennio e da diverse tornate elettorali. L’ “America first” di Trump nel 2016 aveva fatto breccia conquistando le fasce della popolazione più in crisi dal punto di vista economico e sociale con l’impegno di dedicarsi in prim’ordine alle loro necessità piuttosto che sperperare soldi in inconcludenti campagne in aree del mondo lontane e spesso per loro completamente sconosciute e giudicate irrilevanti.
La vera novità di queste ultime settimane è la constatazione che i Democrats, e quindi non solo Biden ma tutto l’apparato di potere che c’è dietro, a partire dall’influenza che ancora ha una figura come Barack Obama, non hanno solo opportunisticamente seguito Trump su quel terreno per poterlo battere nel 2020, ma si sono definitivamente convinti della bontà di quell’assunto: gli interessi americani non si perseguono esercitando a tutti i costi un ruolo, fondamentale ma dispersivo, di egemonia mondiale, ma focalizzandosi al meglio sulla cura del proprio orto e difendendolo solo là dove è necessario.
Per contro, il criterio usato da sempre per definire il “dove è necessario” rimane quello dell’interesse economico e strategico. E non c’è dubbio che, ormai, alla vecchia rivalità USA-Russia, con l’Europa fondamentale in funzione di “cuscinetto” amico, e alla più recente contrapposizione post 11-settembre contro i regimi e le organizzazioni terroristiche di matrice islamista-fondamentalista, che ha accomunato l’intero mondo occidentale, si sia sovrapposta come priorità la “vigile attenzione” verso la grande superpotenza emergente nel teatro globale: la Cina. Presente a tutto campo, con una politica di espansione economica “aggressiva”, alla ricerca di sponde in tutti i continenti, compresa l’Europa e la stessa America, e margini di crescita ancora indeterminati, il Dragone si propone come il più solido concorrente degli Usa e del modello socio-economico occidentale, in particolare sul terreno del progresso tecnologico avanzato, dalla cybersicurezza alle telecomunicazioni alla corsa allo spazio. Comincia a serpeggiare la presa di coscienza che chi compie adesso lo scatto decisivo “dominerà il mondo” per molti anni a venire.
Obiettivo: de-escalation
Non deve perciò sorprendere che gli USA proprio con la presidenza Biden abbiano portato a compimento un progetto già annunciato da tempo e più volte, ossia quello di abbandonare al proprio destino le aree del mondo non essenziali ai loro interessi, per concentrarsi invece sulle “minacce rilevanti”. Dopo tanti annunci e dopo un’applicazione più nei proclami che nei fatti da parte di Trump che, sì, ha preparato il terreno schiacciando il freno circa la presenza americana in molti scenari di conflitto, dalla Siria alla Libia, ma in maniera più estemporanea che pianificata e senza mai mollare del tutto la presa (e comunque senza rinunciare a far sentire tutto il peso degli Stati Uniti quando serviva, intervenendo spesso a gamba tesa ad esempio nei rapporti tra Gran Bretagna ed Unione Europea o contro la Corea del Nord di Kim Jong-Un), ora sembra che i tempi per un reale cambio di passo nell’approccio geopolitico USA siano definitivamente maturati.
La stessa amministrazione al potere ha sentito come ineludibile, per risultare credibile agli occhi di chi l’ha votata, un “controllo di qualità” sulle operazioni militari e di intelligence, spesso negli ultimi anni mal organizzate e poco proficue, in varie parti del mondo e progressivamente parrebbe aver fatto partire un’analisi complessa e un processo di verifica di tutti i dossier aperti che li vedono protagonisti attivi in politica estera. E’ presto per dire che si sia davvero di fronte a un reale e consapevole cambio di ruolo degli USA nello scacchiere mondiale. Ma anche solo aver iniziato il processo di ripulitura dagli “useless” o “corrupted” files del modello operativo USA in campo internazionale testimonia due cose: che anche un mastodonte come gli Stati Uniti sentono la crisi e si rendono conto di non avere sufficienti risorse umane e materiali disponibili per continuare a coprire con efficacia l’intero globo e che questo “quality check” del sistema ha lo scopo di riversare sulle questioni invece rilevanti tutte le risorse supplementari così rastrellate.
Nel nome della discontinuità
Detto dunque che non si può trovare sorprendente che gli USA abbiano identificato la Cina come il loro “competitor” principale e riversino su di essa tutte le risorse e le attenzioni, a scapito di altre situazioni dalla rilevanza non più attuale, quello che sorprende è semmai la tempistica e la modalità con cui le ultime decisioni sono state assunte. E la conseguenza implicita che ne deriva.
Il ritiro delle truppe dall’Afghanistan infatti è risultato mal preparato sia a livello politico sia a livello logistico. Si è scelto di abbandonare l’area per portare fino in fondo la presa di posizione assunta e per tirarsi fuori il prima possibile da una fonte di spreco di risorse umane e materiali. La decisione doveva essere uno dei fiori all’occhiello di questo primo anno della politica di Biden, dimostrando agli americani che lui andava fino in fondo alle promesse fatte in campagna elettorale. Un obiettivo mediatico significativamente palesato anche in occasione del primo discorso da presidente nella sede dell’Assemblea Generale dell’ONU, dove ha potuto dichiarare ai suoi elettori e al mondo: «Per la prima volta negli ultimi vent’anni gli Stati Uniti non sono in guerra». Era questo lo scopo primario della tempistica apparentemente affrettata del ritiro: marcare fin da subito con un segno tangibile di discontinuità la sua azione da Presidente.
La poca attenzione nel preparare il terreno a una transizione controllata ha invece finito per trasformare il tutto in una débâcle diplomatica e mediatica e se vogliamo anche militare, con la rapida presa di potere dei Talebani, l’attacco suicida all’aeroporto di Kabul e l’ammissione dell’errore del drone che doveva attaccare membri dell’Isis per rappresaglia e ha finito invece con l’uccidere 10 civili. Tuttavia, laddove le imperizie militari e strategiche rivelano (non da ora) un preoccupante deficit di comprensione delle dinamiche interne delle zone dove gli USA decidono di operare, la rapidità della ritirata, da tutti vissuta come una vera e propria fuga, testimonia invece, paradossalmente, del decisionismo di cui lo staff di politica estera di Biden vuole innervare la propria azione politica. Decido una cosa e la faccio perché ritengo sia la cosa giusta da fare adesso, le conseguenze le affronteremo e le risolveremo poi.
Lo schiaffo dell’Aukas
Stessa modalità seguita nell’annuncio dell’alleanza strategica con Australia e Gran Bretagna nel sud Pacifico. Una zona dove gli interessi in gioco sono molteplici da parte di molti attori. Con la Cina impegnata a puntellare la sua presenza economica e militare nell’area (e col sogno nemmeno troppo velato, in prospettiva, dopo averlo fatto in punta di diritto internazionale con Hong Kong, di riannettere con le buone o con le cattive alla Repubblica Popolare quella che essa continua a – e impone alla comunità internazionale di – considerare una provincia ribelle, ossia Taiwan, al motto di “Una sola Cina”), gli Stati Uniti hanno ritenuto necessario stringere i rapporti con i paesi amici e, soprattutto, muoversi sottotraccia per non scoprire i giochi. Ecco così la “triplice alleanza” dell’ Aukus (Au+Uk+Us), che però ha totalmente spiazzato un alleato storico come la Francia che nell’area del Pacifico ha diversi interessi, oltre a una presenza “fisica” che si poggia sui territori e sulle collettività d’Oltremare, dalla Polinesia francese alla Nuova Caledonia, ma che soprattutto aveva stretto con l’Australia un accordo da miliardi di Euro in favore dell’azienda francese Naval Group per la fornitura di 12 sottomarini, accordo spazzato via unilateralmente dall’Australia in seguito all’alleanza con USA e GB. Intralciare così smaccatamente gli interessi di un alleato, tenendolo peraltro all’oscuro fino all’ultimo, è uno strappo diplomatico deflagrante (e infatti la Francia ha reagito richiamando gli ambasciatori da Washington e Canberra, un’azione che nel linguaggio diplomatico significa più o meno “Rambo al nostro confronto era calmo”) ma è al contempo indicativo della considerazione che gli USA riservano, al momento, a degli alleati storici e leali ma che risultano distanti e non più utili, anzi quasi una zavorra, ora che la “zona nevralgica” degli interessi americani si è spostata dal confronto con la Russia, che rimane, ma viene trattato direttamente e ad alti livelli, a quello con la Cina.
Il partner privilegiato dall’altra sponda dell’Atlantico, attraverso cui l’amministrazione USA ritiene di poter tenere il piede nell’area, e le scelte recenti lo hanno dimostrato una volta ancora, è semmai la Gran Bretagna di Boris Johnson, unita a Washington da approccio neoliberista al mercato, lingua e se vogliamo anche principi e legami storico-giuridici comuni. Sono molte le dinamiche dell’Unione che risultano indigeste o a volte persino incomprensibili all’approccio di Washington, che non vuole farsi impaludare dai mille cavilli e dalle resistenze che per gli europei sono elemento imprescindibile per la stessa esistenza dell’Unione nella sua forma. La necessità di avere un partner che parlasse a una voce sola ha portato gli USA a disinteressarsi sempre più della regione europea, ormai stabilizzata e che al momento riveste semmai il ruolo di “regione da tenere d’occhio” più che “regione amica”.
Lo schiaffo alla Francia è implicitamente uno schiaffo all’Europa tutta, insomma, per come è costruita, ed è la dimostrazione che gli USA “non vedono” proprio il Vecchio Continente nelle loro mosse strategiche, al punto da concedersi persino il lusso di creare una gaffe planetaria pur di non essere rallentati nel perseguire i loro interessi le loro scelte strategiche.
Effetto “sliding doors” per l’Europa
Questo nella migliore delle ipotesi. L’alternativa, è che vi sia stata una deliberata manovra per indebolire un alleato scomodo, al presentarsi dell’occasione. Sia come sia, l’evento in sé lascia l’Europa nuda e non è un caso che la prima reazione del ministro degli Esteri francese Le Drian sia stato evocare neanche troppo velatamente un futuro fosco per la NATO. Al di là degli inevitabili proclami mediatici, è ovvio che l’Europa e la Francia in primis non possano voltare le spalle all’alleato principe degli ultimi settant’anni e rinunciare all’ombrello che agire di concerto alla forza militare e politica della democrazia americana garantisce. Così come è altrettanto ovvio che gli USA dovranno dare dimostrazione di non considerare l’Europa un alleato scontato da gestire distrattamente, se vorranno mantenere inalterata l’influenza su di essi, poiché l’unione di intenti delle democrazie mondiali è troppo importante a livello mediatico e strategico per rinunciarvi a cuor leggero e per eccessiva protervia.
Tuttavia, in particolare adesso che è giunta definitivamente al termine l’era di Angela Markel, la cui innegabile seppur controversa leadership ha avuto l’effetto di dare almeno un indirizzo e una compattezza di facciata a un carrozzone tutt’altro che omogeneo nelle sue composite istanze, gli stati Europei si trovano davvero a un momento “sliding doors”. Sarà in grado chi le succederà alla guida della locomotiva tedesca di trainare il treno europeo con altrettanto connubio di germanico polso fermo e non meno tedesca razionalità? Sarà in grado di raccoglierne il testimone Macron, che nei prossimi mesi sarà inevitabilmente risucchiato dalla campagna elettorale per le Presidenziali Francesi del 14 maggio 2022? Saranno in grado la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli di dare una voce comune e offrire un’immagine di compattezza delle istituzioni del Vecchio Continente, creando una sintesi tra le molteplici istanze degli stati membri senza che finiscano per sabotarsi a vicenda e senza incorrere in imbarazzanti episodi come quello del sofagate in presenza di Erdogan nell’aprile scorso?
Tutte le strade portano a Roma
In questo senso emerge come figura potenzialmente cardine dell’azione congiunta dei Paesi membri il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Per curriculum, caratura, contatti di alto livello, ruolo attuale di leader di quello che rimane uno dei paesi fondatori e ancora oggi terza forza industriale ed economica dell’UE, mai come adesso l’Italia ha la possibilità di giocare il suo jolly nell’influenzare le scelte europee. Un jolly che il calendario della diplomazia le permette di giocare anche in casa. Il 30 e 31 ottobre prossimi è infatti in programma a Roma il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20. Non è un caso che appena il giorno prima che Biden parlasse all’ONU in assemblea plenaria, Draghi sia intervenuto in quella stessa sede nell’ambito dell’evento “Climate Moment”. Un discorso incisivo e svolto facendosi carico, di fatto, del ruolo di portavoce dell’Europa sull’argomento. Un modo per marcare il territorio e poter trattare il più possibile “ad armi pari” con gli USA su una questione ormai dirimente dell’azione politica internazionale e su cui i contrasti tra le due sponde dell’Atlantico sono tutt’altro che sotto traccia. Il G20 di Roma diventa dunque l’inevitabile campo di confronto per mettere sul piatto, a tutti i livelli, tutte le questioni irrisolte e decidere come impostare i reciproci rapporti nella futura azione di indirizzo del pianeta. Entrambi gli attori vi arrivano indeboliti e divisi sulla strada da seguire con il terzo grande attore in scena, ossia la Cina di cui sopra. In essa, infatti, i paesi europei vedono non necessariamente un rivale, ma un’occasione di partnership e di crescita, al netto delle ovvie differenze sostanziali in ambito culturale ed etico-sociale. Più o meno tutti i 27 membri dell’Europa puntano a realizzare accordi commerciali, scambi culturali vantaggiosi per entrambe le parti e Un atteggiamento che gli USA, oggi molto più netti nel considerare la Cina ormai aliena agli interessi americani, considerano terreno per creare un eventuale cavallo di troia nel consesso occidentale. Ecco dunque il vero terreno di scontro a cui tutto porta, e la vera questione che mette a rischio i rapporti futuri: gli interessi perseguiti da USA Europa non collimano più.
Tutti per uno, o ognuno per conto suo?
Vedremo prossimamente come la Cina stia sapientemente facendo sponda anche su queste discrasie nell’ovvio e più o meno dichiarato obiettivo di “dividere et imperare” attraverso una crescita e un’azione invece costante e coerente. Per chiudere il discorso, rimane l’impressione che gli USA abbiano varcato un punto di non ritorno nella loro azione diplomatica, non muovendosi più “di concerto” con le altre potenze con cui ha rapporti diplomatici di alto livello, ma del tutto autonomamente. Un atteggiamento che per altro ha caratterizzato da sempre anche il rapporto dei singoli paesi membri con l’Unione Europea, cui nessuno, a partire dalla Francia, ha mai avuto intenzione di cedere minimamente parti di sovranità discriminanti dello status di (perdonate il gioco di parole) stato indipendente. Una contraddizione che prima o poi dovrà trovare un compimento, come lo stesso Draghi aveva puntualizzato durante la conferenza EU MED 9 di Atene appena pochi giorni fa incitando a scelte più coraggiose riguardo alla difesa comune e a una maggior integrazione nelle politiche economiche, energetiche e sanitarie. Altrimenti, saranno sempre più i casi in cui un singolo membro si muoverà in solitaria finendo per fare danno a se stesso e agli altri membri dell’UE come una scheggia impazzita come nel caso della crisi dei sottomarini.
A tal proposito, la difesa del premier australiano riguardo alla scelta di stracciare l’accordo con la Francia è stato che i sottomarini francesi risultassero obsoleti e comportassero un aggravio di costi e ritardi nella consegna rispetto a quanto pattuito nel 2016. Per quanto strumentale, anche questo, a suo, modo, testimonia quanto i paesi Europei, anche quelli teoricamente più avanzati industrialmente e tecnologicamente come la Francia, inizino a perdere colpi riguardo agli standard di eccellenza richiesti dal mercato: il mondo corre, se l’Europa non cambia ritmo e non si fa trovare preparata e compatta nella gestione delle sue risorse, disperdendosi invece in cattiva gestione e rivalità interne, rischia di farsi doppiare nella corsa dei paesi tecnologicamente avanzati nel giro di pochi anni, con tutto ciò che ne consegue in termini di benessere dei suoi cittadini.